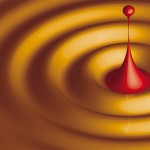Sacro & Profano
PAGNOTTA PASQUALE & MIGLIACCIO
Sacro“di Catia Guerrini” La Pagnotta Pasquale è un dolce molto radicato a Sarsina e in tutta la valle a cui le popolazioni locali non hanno mai rinunciato. I segreti della sua lavorazione sono stati consegnati da suocera in nuora, attraverso regole codificate in quel teatro domestico che variava copione e commedia a seconda dei periodi dell’anno: la cucina. Una vera e propria drammatizzazione della moglie del capofamiglia, in funzione del territorio, del suo clima e dei suoi frutti, che richiedeva purezza nell’animo, pazienza e saperi ereditati secondo i propri codici familiari.
Tutto aveva inizio nella Settimana Santa, anzi, il clima dei preparativi, cominciava a diffondersi nell’animo delle “azdore” fin dalle Sacre Ceneri, da quel momento e per tutti i quaranta giorni di quaresima, l’“azdora” era pervasa da uno strano senso di euforia, ma anche di angoscia, perché viveva la responsabilità di chi deve realizzare un’opera che oltre a segnare i rituali della Pasqua e rappresentare per il clan familiare, il dolce più importante dell’anno, diventava motivo di confronto e condivisione, creando a sua volta elementi di socializzazione e di identità. L’ “azdora” viveva questo processo di manipolazione e trasformazione come un “travaglio”, era richiesta purezza nel corpo e nell’anima, non poteva entrare in scena se mestruata, perché avrebbe potuto contaminare e rendere sterile quella essenza che dà la vita all’opera: il lievito madre.
Lieta nell’animo e candidi i suoi costumi, l’ “azdora” entrava in scena facendo rinvenire quella pastella secca del lievito madre lasciato dalla precedente panificazione, corpo giacente al quale doveva ridare nuova vita, nuova forza generatrice e propulsiva di tutta l’opera: questo il miracolo! Così al calare della sera di un giorno della settimana Santa, ma raramente di venerdì perché giorno della Passione di Cristo, ella calava in una pentola di acqua tiepida questa “anima” e cospargeva la sua superficie con manciate di farina per facilitare la rappresentazione del simbolo della croce racchiuso all’interno di un cerchio, affinché tutto il lievito si rinvenisse uniformemente. Recitava la benedizione del Padre, Figlio, Spirito, Santo, talvolta i nomi della Trinità venivano sostituiti da numeri, mentre la mano segnava le quattro estremità della croce. Ognuna recitava una formula appartenente al sapere o ai codici familiari.
Dopo aver riattizzato il fuoco soffocato durante la notte, procedeva a mescolare dentro una pentola: uova, (alcune delle quali benedette), il latte fatto riscaldare precedentemente per non correre il rischio di bloccare poi la lievitazione, lo strutto del maiale, lo zucchero, il limone grattugiato, talvolta la buccia d’arancia anch’essa grattugiata, fatta essiccare nel camino durante l’inverno, infilata dentro un filo come una collana, la vanillina e per ultimo l’anice o mistrà. Le arance erano un frutto “ a rischio”: spesso le “azdore” non le usavano, perché avrebbero potuto far diventare le pagnotte “rosse”, e questo era assolutamente un “pericolo” da evitare! Le pagnotte venivano modellate una ad una con le mani cosparse di olio, alimento prezioso da utilizzare solo nelle occasioni speciali, che le avrebbe rese lucenti e ancor più fini al tatto, poi la forza di braccia e fianchi ancheggianti ritmati scandivano i tempi di lavorazione, plasmando pagnotte a forma sferica o di cupola o se si vuole di un ventre rigonfio.
Le pagnotte di Pasqua venivano messe a lievitare quasi sempre nel letto matrimoniale dell’ “azdora”, con il “prete”: una impalcatura di legno usata per scaldare il letto nelle fredde notti invernali, sulla cui base inferiore veniva posto uno scaldino con la brace, coperto di cenere in modo che non bruciasse le lenzuola e diffondesse il tepore necessario per permettere alle pagnotte di crescere e lievitare. A volte si cambiavano le lenzuola per l’occasione, e poche persone oltre all’azdora” potevano varcare la soglia di quella camera da letto che diventava così luogo proibito, (interdizione che fa del letto un luogo sacro simile ad un tabernacolo). Le pagnotte vicine l’una all’altra venivano protette da più coperte e lasciate sotto quel tiepido calore per diverse ore, trovando in quel “sudario” le condizioni ottimali per esprimersi verso l’alto! Simulazione del corpo divino, forse.
Prima di essere infornate, le pagnotte venivano spennellate d’uovo con le mani o con una penna di gallina o meglio ancora con una penna di gallo, così da risultare dorate come il sole.
Anzi, per evitare che prendessero la punta del “rosso”, quando erano dentro al forno le Pagnotte venivano coperte con della carta, proprio per scongiurare il pericolo di un colore per loro così “cruento” e “impuro”. Ma dovevano sottostare ad un altro rituale: sulla cupola della Pagnotta si faceva una incisione che a volte coincideva con una croce, altre con una mezza luna. Sul lastrone generalmente di arenarie o di ferro, veniva disegnato con la pala il simbolo della croce. Le pagnotte erano cotte quando risultavano essere del colore dell’oro, venivano tolte dal forno una ad una e fatte raffreddare sopra l’asse del pane, poi chiuse nella madia fino al giorno di Resurrezione.
Nel giorno di Pasqua, al ritorno dalla Messa, la famiglia riunita attorno ad una bella tavola imbandita accoglieva questo fiore di primavera, in comunione con uova sode benedette, salame stagionato e Sangiovese. Nei giorni a venire, la Pagnotta era mostrata, donata e scambiata con le famiglie del vicinato in un clima di festosa reciprocità. Corpo culinario espressione di sentimenti, dato in dono alle famiglie per il piacere di mostrarne la bellezza, la consistenza, l’armoniosità, le rotondità per poi riscontrare l’ammirazione e lo stupore sul volto di chi lo riceveva. Ogni “azdora” era convinta che la propria Pagnotta fosse la migliore, perché custode di una ricetta o un ingrediente segreto da non poter rivelare a nessuno! Questo scambio diventava forte elemento di socializzazione e di una consapevole identità riconosciuta dall’esterno, rinsaldando rapporti di amicizia, di parentela dove il bene culturale rappresenta il patrimonio delle proprie radici. L’impulso vitale alla conservazione è dato proprio dall’unione del salame con le uova sode:da una parte la Pagnotta, simulacro di un corpo gravido, dall’altra uova e salame, allusioni al corpo maschile.
Profano
“di Catia Guerrini” Il salame come rientra in quella condivisione, nella mattina di Pasqua? Il salame era il frutto di un rituale compiuto tra Natale e l’Epifania, che vedeva coinvolta la comunità in un clima di reciprocità, in una drammatizzazione di rituali pagani, opposto a quello seguito per la Pagnotta Pasquale.
Così in una fredda mattina d’inverno tra Natale e l’Epifania un gruppo di uomini compiva il sacrificio, rito di socializzazione “pagana”: un maiale preso per la zampe veniva appeso a testa in giù su una finestra dell’aia e tra lamenti e urla veniva scannato per la gioia dei partecipanti. Il “primo” sangue che fuoriusciva dalla ferita inferta alla giugulare veniva raccolto dentro una pentola, da un uomo o da una donna, che con una chiave di ferro, posta sul fondo o tenuta in mano, si impegnava in un movimento rotatorio, facendo girare il sangue sempre dalla stessa parte affinché non coagulasse.
Spesso nelle tradizioni popolari il segno assume un significato magico e la chiave non apre più solamente la porta di casa, ma anche quella del potere, della conoscenza e del dominio.
Nel caso specifico la chiave veniva usata dentro quel sangue che sarebbe servito per fare il Migliaccio, un dolce che era espressione e frutto dell’inverno, come lo era il salame che maturato nel tempo, trovava poi con la pagnotta un legame perfetto. Il Migliaccio era un dolce che richiedeva un lungo e paziente lavoro da parte dell’ “azdora”, ma soprattutto la vedeva protagonista di un grande senso del dovere, perché ella non manipolava volentieri quel sangue, per lei elemento di contaminazione, eppure doveva.
CCosì il giorno dopo il sacrificio, dentro una pentola univa al sangue, il latte, lo zucchero, le uova, il limone, i canditi, la cannella, il pane bagnato nel brodo ed infine il cacao, alimento magico che con una sorta di alchimia faceva scomparire quella natura contaminante del sangue dell’animale, che l’ “azdora” viveva con disagio. Una sfoglia di farina ed acqua (pasta matta per l’Artusi) diventava la base, posta sulla teglia di rame, dentro la quale venivano versati gli ingredienti, a volte tra la sfoglia e la farcia si stendeva un velo di miele. Spesso la teglia di rame era più grande dell’aiola del camino quindi il dolce si cuoceva nel centro della cucina, direttamente sul pavimento, si metteva la brace ardente per terra e sopra al treppiedi si appoggiava la teglia, che veniva sigillata con il suo coperchio, sopra al quale si metteva altra brace, usando i tralci delle viti perché formavano una brace più fine ed uniforme, ideale per cuocere questo dolce che vuole un calore tiepido ed unito. I tralci delle viti erano e sono presenti nelle nostre colline ma si può anche tener conto di come fossero ritenuti dalle culture semitiche l’ “albero del mondo”, il primigenio vegetale dal quale tutto avrebbe avuto origine.
La raffigurazione dei sarmenti in maniera ordinata e stilizzata presente in motivi architettonici e decorativi di chiese e moschee, ne attesta in modo inequivocabile l’importanza. Il Migliaccio si cuoceva in un lungo tempo, anche di più ore, terminava quando l’ “azdora” con un bastoncino di legno infilato nell’impasto, verificava che uscisse pulito, poi veniva spennellato di rosolio utilizzando una penna di gallina o di gallo, affinché il suo colore risultasse ancora più sanguigno allo sguardo. La cuoca in questa manipolazione mette in gioco pratiche che uniscono il nascondere e il mostrare: l’elemento abbietto del sangue è nascosto dal cacao ed esaltato dal rosolio. Lo tagliava in molti pezzi a forma di “rombo”, divenuta poi una unità di misura “popolare”, tanto che ne nasce una frase idiomatica: ”a misura de miec”, per indicare la forma del rombo. Non si è mai sentito dire che qualcuno abbia tagliato il Migliaccio in una forma diversa. Un riferimento a questa figura geometrica lo si trova nella simbologia antica che indica una piramide come simbolo maschile e una piramide rovesciata ( o coppa) come simbolo femminile. Giocando e congiungendo la base delle due figure ne risulta il rombo, simbolo maschile e femminile che si uniscono! Il Migliaccio veniva mangiato da tutta la famiglia, era molto gradito dagli uomini e come la Pagnotta veniva donato e scambiato dalle famiglie, creando coesione, socializzazione e identità. Erano gli unici due dolci che durante l’anno venivano scambiati e donati, mentre gli altri dolci si offrivano solo se veniva un ospite in casa.
Guerrini C.(2005) La Pagnotta Pasquale e il Migliaccio- L’etica del bello e l’estetica dell’abbietto-“dolci” rituali in Val Savio.
Catia Guerrini, laureata in sociologia ed esperta in comunicazione di culture gastronomiche. Ha frequentato e concluso il master “Le Rotte del Gusto” con la realizzazione di un progetto di comunicazione in cui ha presentato il suo saggio sopra citato.